Il mondo intorno a noi sta cambiando, da qualche giorno a questa parte lo ha già fatto. Molte delle attività che consideravamo scontate, naturali, di fatto non lo sono più. Sono in pausa. Le lunghe cene con gli amici, i concerti, gli aperitivi. Ce ne rimangono però altre, e non meno degne. Ci sono i libri, che in tempi come questi offrono oltre che sollievo, anche una possibilità di evasione. Ci si immerge, lettera dopo lettera, frase dopo frase, e pian piano da una pagina in bianco e nero possiamo perderci in boschi, praterie, piazze e città esotiche dove non siamo mai stati prima. Una volta ancora, in soccorso nei momenti di difficoltà viene la cultura. #letteraturedaquarantena
Il calcio e il teatro come passioni, le vere università della vita. Così lo scrittore Albert Camus amava definirli. Il filo della sua esistenza collega i campi di Algeri, dove da giovane difendeva i pali del Racing Universitaire, con il “palcoscenico dell’impossibile”, sul quale amava rappresentare l’eterno conflitto tra la conoscenza e l’indecifrabilità del mondo. Da portiere ad attore. Due figure solitarie che rifiutano l’individualismo e cercano la loro dimensione nel rapporto con la comunità. Il bisogno di socialità e solidarietà verso l’altro sono il cuore de La peste, suo romanzo del 1947, nel quale una tragedia collettiva spinge gli uomini ad aggrapparsi ai valori più profondi dell’esistenza umana.
La storia è ambientata nella sua terra d’origine, l’Algeria francese, dove Camus era nato e vissuto fino agli anni ‘40, quando si era trasferito a Parigi. La città di Orano, che “volge le spalle al mare”, è colpita da una morìa di topi. Dopo le prime vittime umane, l’allarme aumenta e il dottor Bernard Rieux, protagonista del racconto, non ha dubbi: si tratta di peste. Per limitare la trasmissione del morbo, il centro abitato viene isolato dal resto del mondo.
«(…) ma una volta chiuse le porte, si accorsero di essere tutti, e anche lo stesso narratore, presi nel medesimo sacco e che bisognava cavarsela. In tal modo, ad esempio, un sentimento sì individuale come la separazione da una sola persona cara diventò subito, sin dalle prime settimane, lo stesso di tutto un popolo, e, insieme con la paura, la principale sofferenza di quel lungo periodo d’esilio.” (….) “in verità ci vollero parecchi giorni prima che ci rendessimo conto di trovarci in una situazione senza compromesso, in cui le parole “transigere”, “favore”, “eccezione” non avevano più significato».
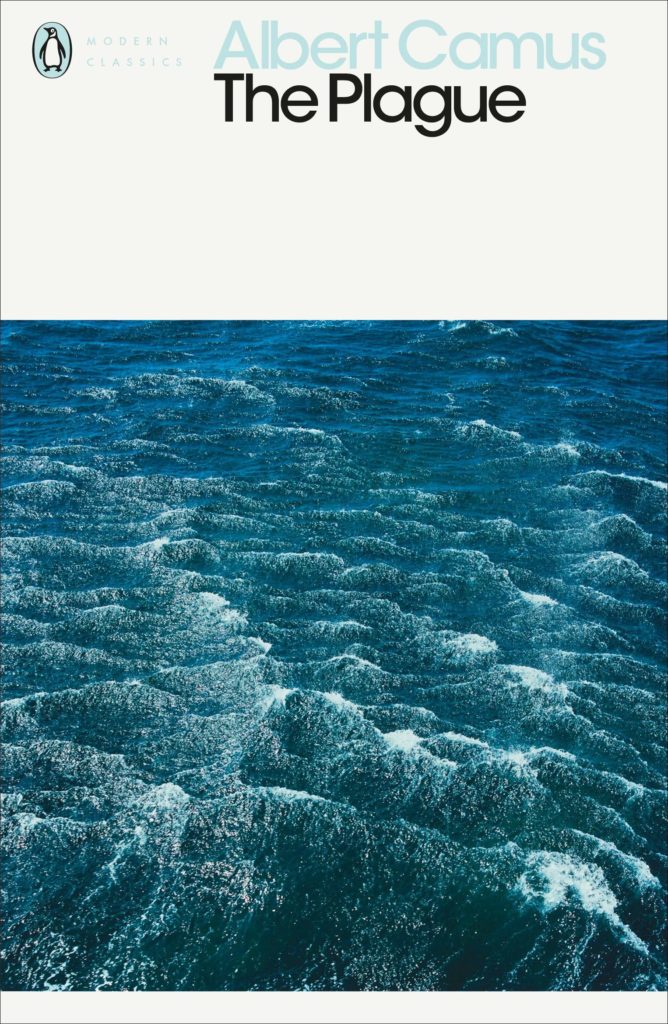
Nel romanzo Camus si finge narratore in terza persona, raccontando lo svolgimento dei fatti attraverso la figura di Rieux, che solo alla fine si scoprirà essere l’alter ego dello scrittore. Il virtuosismo letterario gli serve per una cronaca oggettiva, strumento necessario per calarsi nell’ ”universo” della peste e riportare fedelmente al lettore ciò che vive, assapora. È qui che il medico dimostra il suo profondo legame con la comunità. Narrando le proprie difficoltà e paure, riesce a dar voce a quelle degli abitanti di Orano e la sua identità si realizza nell’aiuto concreto verso chiunque ne abbia bisogno. Per ogni cittadino l’epidemia è l’occasione per porsi domande etiche, morali e per rivalutare il rapporto con l’altro, diventato una persona da aiutare, ma anche una minaccia, un possibile vettore di contagio. La vita all’interno delle mura è difficile e in questo variegato microcosmo le persone, smarrite, reagiscono in maniera diversa, manifestando indifferenza, idealismo, rassegnazione, altruismo.
Nei capitoli finali, grazie al contributo dell’amico Castel, il protagonista trova un siero in grado di guarire i contagiati, liberando la città dall’isolamento. Al termine della storia racconta la gioia che travolge la popolazione quando si riaprono le porte. Si accorge, però, che la gente vuole dimenticare e far finta che la peste non sia mai esistita. Per lui, invece, la vita non sarà più la stessa, perché la memoria di quell’esperienza non può essere cancellata. Malinconico, il dottore fissa Orano e riflette. Ne è certo. Non si può escludere un ritorno della malattia.
Per quanto contagiosa, un’infezione può essere debellata. Al contrario, secondo Camus, nessuna vittoria può essere definitiva e assoluta: «il bacillo della peste non muore né scompare mai (…)». Per l’autore l’epidemia va oltre la biologia. È la metafora della fragilità umana, del male universale, che colpisce gli uomini e come un batterio li contagia in maniera subdola e imprevedibile. È parte integrante dell’esistenza. L’unica soluzione è agire, cercando risorse nella voglia di riscatto della collettività.
Anche l’allegoria della guerra è ben evidente. Camus denuncia quel male che negli anni Quaranta dilaga in Europa con il nome di nazionalsocialismo, diventato inarrestabile perché sottovalutato ai primi sintomi. Proprio come accade a Rieux e ai suoi concittadini alla vista del primo ratto morto.
Significativo come lo scrittore algerino abbia scelto una malattia infettiva per denunciare il nazismo. Lui che da giovane si era ammalato di tubercolosi e per questo motivo era stato costretto ad abbandonare l’amato pallone.

