In italiano vuol dire bisturi, a indicare l’estrema precisione del suo scopo: la corretta informazione in campo medico, portata avanti da quasi duecento anni. È infatti il 1823, quando The Lancet viene fondato dal chirurgo e politico britannico Thomas Wakley, undicesimo rampollo di una ricca famiglia contadina del Devonshire, contea nel Sud-Ovest del Paese.
Lo scorso 20 luglio un articolo pubblicato dalla celebre rivista inglese ha generato ottimismo all’interno della comunità scientifica. Riguarda il vaccino anti-COVID-19 che lo Jenner Institute dell’Università di Oxford sta sviluppando in collaborazione con l’azienda italiana Advent del Gruppo IRBM di Pomezia, a 30 chilometri da Roma. Uno dei 23 progetti internazionali giunti ai test sull’uomo, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’articolo riporta i risultati delle fasi 1 e 2 della sperimentazione clinica, i primi stadi in cui vengono valutate efficacia, sicurezza e immunogenicità del medicinale, cioè la capacità di evocare una risposta immunitaria.
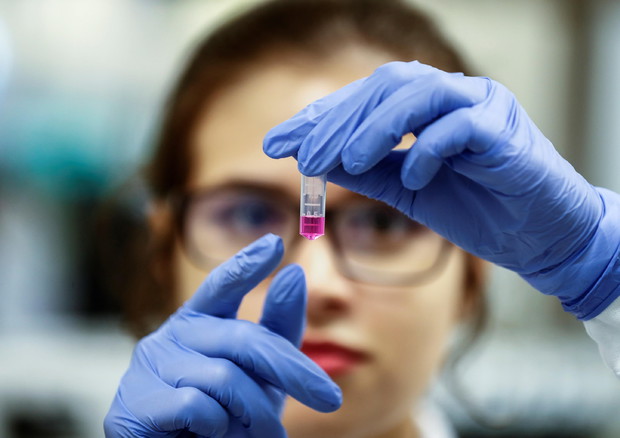
Condotto in cinque centri del Regno Unito, dal 23 aprile al 21 maggio 2020, si tratta di uno studio controllato randomizzato e in singolo cieco: partecipanti ignari del trattamento a cui vengono sottoposti (al contrario degli operatori sanitari) e casuale assegnazione ai due gruppi, sperimentale e di controllo. In questo modo, l’attribuzione random del nuovo farmaco, o di quello di confronto, rende le due popolazioni simili in tutte le caratteristiche, a eccezione del medicinale assunto. Si attribuisce così ogni differenza di risultati al trattamento.
1077 gli adulti sani arruolati, tutti tra 18 e 55 anni. A 543 soggetti è stato somministrato il prodotto della collaborazione italo-britannica, ribattezzato ChAdOx1 nCoV-19. Questo è costituito da un vettore sintetizzato a Pomezia, cioè un microrganismo che veicola l’acido nucleico del Coronavirus per innescare la risposta immunitaria. Si tratta della versione attenuata dell’adenovirus dello scimpanzé, l’agente del raffreddore comune nelle scimmie, modificato in laboratorio e reso innocuo nei confronti dell’uomo. Mediante tecniche di ingegneria molecolare, è stata inserita una porzione del genoma di SARS-CoV-2, quella che codifica per la proteina di superficie Spike e che gli permette l’ingresso nel nostro organismo. Gli altri 534 individui del gruppo controllo, invece, hanno ricevuto il MenACWY, un vaccino autorizzato contro il meningococco di tipo A, C, W e Y.
Sicuro e ben tollerato, con una risposta immunitaria forte e prolungata. Queste le conclusioni dell’articolo. Ma come interpretarle? Ce lo ha spiegato Massimo Andreoni, direttore della U.O.C (Unità Operativa Complessa) Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma.

Professore, quali sono i vantaggi e i punti deboli dello studio?
«Nel complesso i risultati sono promettenti, ma alcuni aspetti vanno approfonditi. La buona notizia è che questo vaccino, soprattutto ad alte concentrazioni, stimola sia la risposta cellulare che la produzione di anticorpi, maggiore nel sottogruppo di pazienti che ha ricevuto una seconda dose e in grado di neutralizzare l’agente infettivo nei test di laboratorio. Ma le fasi 1 e 2 sono stadi precoci della sperimentazione, dunque non possiamo affermare che il medicinale sia in grado di prevenire l’infezione. Inoltre, i dati sulla sicurezza sono meno favorevoli, perché in una significativa percentuale di pazienti sono stati segnalati effetti collaterali medio-gravi, come cefalea e malessere. Tuttavia, è un candidato che ha mostrato buona capacità immunogena in un discreto numero di soggetti. Prospettive incoraggianti verso la fase 3, già intrapresa, che valuterà la reale efficacia del vaccino in vivo».
Serve uno studio che valuti il tempo di permanenza degli anticorpi nell’organismo?
«Si, è necessario. E purtroppo richiederà tempo. Il lavoro sembra dimostrare l’esigenza di una seconda dose, perché con il richiamo c’è stato un aumento degli anticorpi, fra cui quelli neutralizzanti. Ho la sensazione che per questa scheda vaccinale occorra più di una somministrazione».
Si riuscirà a raggiungere il traguardo prima del 2021?
«Difficile fare previsioni. In una normale attività di ricerca, le fasi 1 e 2 possono durare fino a 6 anni. In questo caso hanno bruciato le tappe in soli 6 mesi. La terza, però, è quella più lunga, perché bisogna coinvolgere centinaia o migliaia di persone in una zona con ampia circolazione del virus e in seguito valutare se i soggetti sottoposti a profilassi si sono contagiati. Con l’attuale situazione italiana servirebbero anni, ma in regioni endemiche i tempi si accorcerebbero in modo netto e i dati potrebbero essere acquisiti in pochi mesi. Sono fiducioso, ma i termini non sono così immediati. Nella migliore delle ipotesi, una vaccinazione di massa potrebbe essere avviata durante la prossima primavera».
Che percentuale di popolazione dovrà vaccinarsi per debellare la pandemia?
«La regola è sempre la stessa: più la trasmissione del virus avviene per via aerea e in maniera semplice, più la percentuale deve essere alta. Nel caso di SARS-CoV-2, dovrebbe essere vaccinato il 90% della popolazione».
Cosa pensa dello Human Challenge Trial, che consiste nel coinvolgere una persona sana, vaccinarla con un prototipo oggetto di studio e sottoporla al contagio da Coronavirus?
«Sono metodi che abbreviano le tempistiche per valutare l’efficacia di un vaccino. Ma qui parliamo di COVID-19, una malattia potenzialmente mortale. Selezionare candidati con una bassa possibilità che l’infezione evolva in grave malattia, non esclude questa eventualità. Non considero etico sottoporre un soggetto, anche se volontario, a un rischio atteso e che conosciamo».
Lei ha scritto un libro sulle fake news in ambito scientifico, dal titolo “COVID-19 Il virus della paura”. Quanto è importante il contributo di fonti autorevoli nel diffondere informazioni?
«È fondamentale. Le riviste scientifiche di alto livello devono essere il punto di riferimento per noi sanitari, per i media e tutta la popolazione. La valutazione che fanno sui requisiti e sulle modalità di uno studio sono necessarie per dare credibilità a quel lavoro».
Per quanto tempo ancora dovremo convivere con il virus?
«Almeno un anno. Prima è difficile ipotizzare misure che possano eradicarlo. Dobbiamo contenerlo, fare in modo che i piccoli focolai epidemici siano controllati. E dipende da noi, attraverso le mascherine e il distanziamento sociale, e dalla sanità pubblica, grazie ai tamponi, all’isolamento dei malati e al tracciamento dei contatti. Bisogna essere giudiziosi, per quanto ci costi fatica. Allora arriveremo al vaccino. Inutile sperare che il virus scompaia, perché continuerà a circolare. Gli italiani sono stati bravi, chi ha allentato la presa, invece, ha di nuovo fatto i conti con il problema. Non ritengo che SARS-CoV-2 sia più debole, ma questo è poco rilevante. Sarà il nostro comportamento a fare la differenza».

